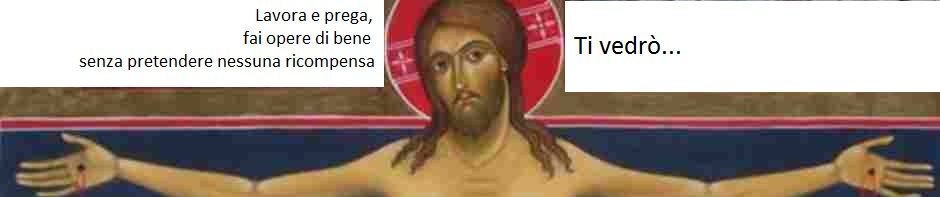Quarto argomento: il dovere universale di amare Dio con tutto il cuore implica il poter metterlo in pratica in ogni stato di vita.
Il comandamento più grande dice di “amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze” [Dt 6,5; Mt 23,5]. Ora, questo precetto con l’aiuto della grazia non è irrealizzabile: “Questo comando […] non è troppo alto per te, né è troppo lontano da te […], anzi è sulla tua bocca e nel tuo cuore, perché tu possa metterlo in pratica” [Dt 30,11]. Infatti, se è un precetto, è rivolto a tutti, e pertanto tutti devono osservarlo: ma se devono, vuol dire che possono; infatti, secondo un celebre assioma, non si dà un dovere se non c’è un potere, e sebbene di fronte a Dio non si possano accampare diritti, tuttavia per Dio, con Dio e in Dio tutto è possibile.
Dal punto di vista biblico, “nulla è impossibile a Dio” [Lc 1,37] e il credente stesso “tutto può in Colui che gli dà forza” [Fil 4,13]; d’altra parte nessuno può accampare diritti con Dio così da “pretendere il contraccambio” [Rm 11,35]. Da un punto di vista filosofico, il principio “se devi, puoi” fornisce un fondamento morale della libertà (come ha acutamente rilevato Kant nella Critica della ragion pratica); d’altra parte questo (come ha acutamente rilevato Kierkegaard nell’Ultimatum di Aut‑Aut) non deve portare ad ammettere tranquillamente la regola “si fa quel che si può”: infatti con le sole nostre forze non siamo mai in grado di sapere con certezza che abbiamo fatto tutto il possibile; è in questo stato di angoscia che si scopre la grazia. Potremmo dire che la grazia è percepita come grazia proprio mediante lo scacco esistenziale di doveri impossibili realizzati misteriosamente. A maggior ragione, da un punto di vista teologico, per chi ha la grazia “i comandamenti non sono gravosi” [1Gv 5,3] ed è pertanto (secondo il Concilio di Trento) necessario e possibile adempierli [cf DS 1536-1539], perché, come dice Agostino, “Dio non ordina l’impossibile” [De natura et gratia 43.50].
Ma se tutti possono osservare i precetti, vuol dire che a maggior ragione il precetto più grande si può vivere (anche se non è detto che poi si viva!) in tutte le condizioni, compreso il matrimonio: dunque anche gli sposi sono in grado di amare Dio con tutto il cuore, ovvero “con cuore indiviso” (anche se non è detto che poi lo facciano).
Il dovere di amare è un’esigenza intrinseca; non un precetto estrinseco al soggetto: la sua paradossalità (in quanto amore comandato) è stata ben illustrata da Bernardo, Kant, Kierkegaard e altri [1]. Nel dovere dell’amore per Dio c’è implicito quello dell’amore per il prossimo, come mostra in maniera emblematica la parabola del buon Samaritano raccontata a Gesù in risposta alla domanda dello scriba sui precetti necessari a salvarsi [cf Lc 10,25-37]: il precetto dell’amore di Dio è illustrato con quello dell’amore per il prossimo (che è “simile al primo” [Mt 22,39], così come l’uomo è a immagine e somiglianza di Dio); ma alla domanda “Chi è il mio prossimo?” fatta dallo scriba, Gesù replica con la domanda “Chi è stato (ossia si è fatto) prossimo del malcapitato?”, indicando così non una regola statica, ma un dinamismo della carità che si allarga a cerchi concentrici, secondo le proprie possibilità e le altrui necessità. Inoltre, nella parabola è chiaro il riferimento escatologico: il Buon Samaritano, ossia il Signore Gesù, anticipa all’albergatore, ossia ad ogni altro uomo (che esercita la carità sempre per un diretto o indiretto coinvolgimento da parte del Signore Gesù, e mai per propria autonoma iniziativa) la possibilità di aiutare e amare, insieme alla promessa che quanto sarà speso in più sarà rifuso al suo ritorno, ossia nella gloria, come anche la parabola matteana del giudizio finale descrive [Mt 25,31-46].
Se il comandamento prescrive di amare Dio con tutto il cuore, ne consegue che avere il cuore diviso è in sé peccato; e del resto (giacché “nulla può mai separarci dall’amore di Cristo”) il cuore può essere diviso da Dio soltanto dal peccato. Ma se la divisione del cuore fosse la condizione essenziale del matrimonio, ne seguirebbe che il matrimonio comporti un peccato, il che è assurdo.
Qualcuno potrebbe dire che nel matrimonio non c’è un peccato, ma c’è una imperfezione. Secondo infatti la tradizione ascetica, rispetto ai comandamenti si può mancare in tre modi: col peccato mortale (quando si agisce contra legem, ossia si manca alla sostanza del comandamento), col peccato veniale (quando pur senza rifiutare la legge si agisce praeter legem e solo di conseguenza e parzialmente contra legem) e con le imperfezioni (quando cioè ci si accontenta del minimo indispensabile, del dettato minimale del comandamento e non si va al “di più” richiesto dal Vangelo). Anche questa obiezione però non può andare, perché sebbene incorrere in questa o quella imperfezione non sia in sé peccato, il decidere sistematicamente di non tendere alla perfezione è un peccato contro il comando di “essere perfetti come è perfetto il Padre” [Mt 5,18].
Secondo la dottrina agostiniana, poiché “misura dell’amare Dio è di amarlo senza misura”, di conseguenza “meno lo ama chi oltre a lui ama alcunché che non per amor suo ama” [2]. Ebbene, in base alla dottrina spirituale di Giovanni della Croce, un acuto manualetto di ascetica nota che
lo sposo può amare la sua sposa in due modi: 1) prescindendo da Dio, e perciò su un piano puramente umano. In questa dimensione il motivo che determina lo sposo ad amare la sua sposa sarà la sposa stessa la quale — per perfetta che sia — è sempre una creatura. Un tale amore sarà perciò fatalmente legato alle doti umane della sposa e limitato ad una dimensione creata di felicità. 2) Se invece lo sposo ama Dio con tutto il cuore, vedrà nella sposa “Dio da amare in lei” e l’amerà con lo stesso amore con cui ama Dio. Allora il suo amore non sarà condizionato dalle doti umane di lei, né teso a procurarle una felicità puramente terrena, ma legato all’amore che egli porta a Dio stesso e teso alla sua eterna unione con lui. Non è chi non veda come questo amore sia superiore al primo! [3]
Insomma, in una prospettiva di consacrazione, lo sposo amerebbe Dio con tutto il cuore e il coniuge e i figli come primizie del prossimo da amare come se stesso; e questo non andrebbe a scapito di Dio (perché è Dio ad aver dato allo sposo la famiglia, e lo sposo amerebbe la sua famiglia in Dio e per Dio); ma non potrebbe nemmeno andare a scapito dei membri della famiglia stessa, perché lo sposo, amandoli in Dio e secondo Dio, tenderebbe ad amarli come li ama Dio (ed essi hanno tutto da guadagnarci). Lo sposo offrirebbe così a Dio tutto il suo cuore vergine, e al coniuge tutto il suo cuore puro (lo stesso cuore, ma su due piani diversi); e così l’alleanza matrimoniale diventerebbe pienamente (in maniera non più solo discendente e sacramentale, ma anche ascendente e spirituale) segno dell’Alleanza di Dio con l’uomo.
Non è dunque il matrimonio a dividere il cuore da Dio, ma semmai il matrimonio vissuto comodamente, senza tendere alla santità.
Quinto argomento: tra i consigli evangelici esplicitamente dati da Gesù in ordine alla sequela in generale non c’è il celibato.
Nella tradizione spirituale si parla di consigli evangelici [4] (ossia dati da Gesù nel vangelo o dati dal altri, specialmente da Paolo, nello spirito del vangelo) al fine di vivere più perfettamente (e non al minimo) i precetti: la tradizione ha visto nel vangelo un precetto laddove Gesù chiede categoricamente di fare o non fare qualcosa, e un consiglio laddove dice invece “se vuoi” (in particolare nel dialogo col giovane ricco).
· I consigli di Paolo
Occorre considerare dapprime i consigli dati da Paolo: in effetti, il termine “consiglio” [«gnóme»] ci viene però da Paolo, che nelle sue lettere a volte dice: “in questo vi do un consiglio” [2Cor 8,10; 1Cor 7,25], a proposito di quelle che potremmo chiamare la povertà e la castità supererogatorie, finalizzate alla ricerca di una maggior carità verso Dio e verso il prossimo.
Una notazione lessicografica: il sintagma ‘consigli evangelici’ risente di una certa oscillazione semantica. A volte, e soprattutto in passato (in particolare per Tommaso) i consigli non sono le virtù evangeliche (di povertà, castità e obbedienza), ma derminate azioni strumentali volte a far crescere in queste virtù, ma in specie nell’amore (per esempio vendere tutto, ovvero rinunciare ad ogni proprietà). Altre volte (e prevalentemente oggi) per consigli evangelici si intendono perlopiù le virtù evangeliche, quali che siano gli strumenti per conseguirle (vincoli sacri e impegni secondo la regola che si abbraccia), purché tali strumenti ci siano e la virtù si traduca in comportamenti concreti. Si tenga presente che nella teologia scolastica, ignorando altre forme di consacrazione oltre a quella religiosa, i consigli evangelici venivano spesso identificati con gli impegni religiosi, dimenticando che in realtà ogni cristiano può e in certa misura deve vivere la povertà, la castità e l’obbedienza, in funzione cioè di una maggior carità: infatti, amare Dio con tutto il cuore esige di dimostrarlo con la rinuncia all’inessenziale, per cercare prima di tutto il Regno di Dio; parallelamente, amare il prossimo come se stessi implica di ridimensionare il proprio io e i propri beni per meglio contribuire alla carità fraterna e favorire la comunione fra gli uomini.
Parlando delle collette per i poveri, Paolo dice: “in questo vi do un consiglio: ciascuno dia con generosità”. Infatti, il privarsi non del superfluo (il che è temperanza dovuta), ma di quanto è necessario per star bene ma non essenziale, ovvero rinunciare a qualche cosa di cui si sentirà la mancanza, non è strettamente di precetto, ma è un consiglio: quello appunto della povertà.
Poi però, Paolo usa il termine consiglio riguardo al celibato. Dopo infatti aver ribadito agli sposati la proibizione di passare a seconde nozze vivente il coniuge fuorché il caso di connubio con un infedele (“Questo non lo ordino io ma il Signore”: si tratta dunque di un precetto); a quelli che sono indecisi se sposarsi oppure no Paolo dice: “Vi do un consiglio, come uno che merita grazia del Signore”, il consiglio appunto di rimanere come si è, di non sposarsi, perché “gli sposi avranno tribolazioni” e Paolo vorrebbe risparmiargliele. E tuttavia Paolo stesso dice che “ciascuno ha il suo carisma da Dio, chi in un modo e chi in un altro”: ossia chi nel matrimonio e chi nel celibato.
Di solito ci si ferma a considerare questo consiglio, e ci si dimentica che nello stesso testo Paolo dà un altro consiglio agli sposati, quello cioè dell’astinenza periodica di comune accordo e “per breve tempo” “per dedicarsi alla preghiera” [5]: questo lo dice “non come precetto” ma “come concessione” (abbiamo visto però come da Origene in poi tale concessione sia stata intesa come un consiglio). Quanto a quella che chiamiamo castità, è vero quindi che Paolo consiglia il celibato, ma agli sposi consiglia invece l’astinenza periodica: due consigli che potremmo oggi comprendere come finalizzati allo stesso frutto, ossia la verginità di cuore. C’è da dire che l’atto coniugale ha (oltre al naturale fine procreativo) la funzione naturale e sovrannaturale di esprimere e alimentare la comunione fra i coniugi, “sacramento in riferimento a Cristo e alla Chiesa”; pertanto, la castità coniugale consisterà non nel limitare la frequenza o l’intensità dell’atto coniugale, ma nell’usarne “tanto quanto” serve ad esprimere e alimentare tale comunione.
E dunque non più del dovuto, ma neanche meno, secondo il senso sapienziale che troviamo rileggendo la Scrittura nella Tradizione: “C’è un tempo per ogni cosa […]: un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci” [Qo 3,1.5b]; “Non per concupiscenza prendo in moglie questa mia parente, ma con rettitudine di intenzione” [Tb 8,7-9] [6]. In questa prospettiva va collocato il caso dell’astinenza perpetua che alcune coppie cristiane (rispondendo ad una ispirazione molto particolare) di comune accordo decidono a un certo punto di praticare in vista del Regno, perché così sentono di poter compiere meglio la propria comunione reciproca e con Dio, sull’esempio di Maria e Giuseppe, a cui Dio ha chiesto di vivere un matrimonio fuori dell’ordinario e tuttavia autentico.
· I consigli di Gesù
Fin qui i consigli paolini, ai quali dobbiamo dare grande valore; dobbiamo perciò darne ancor maggiore ai consigli dati da Gesù stesso, il quale non sembra aver mai dato come consiglio generale quello del celibato.
Alla domanda del giovane ricco (“Che cosa devo fare per avere la vita eterna?”), Gesù risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti” (che sono il minimo indispensabile, ma sufficiente), e li elenca in forma categorica. Quando il giovane dice d’averli sempre osservati e chiede cosa gli manca ancora, Gesù gli risponde: “Una sola cosa ti manca: se vuoi essere perfetto va’, vendi quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi” [Mt 19,17-21].
Il consiglio che Gesù dà è quindi quello di non fermarsi al minimo indispensabile, ma di vivere i comandamenti al massimo, andando oltre la misura della legge. Il consiglio concretamente dato è quello della povertà evangelica (“vendi quello che hai”), intesa come strumentale alla carità verso il prossimo (“dàllo ai poveri”), ma soprattutto come condizione per la sequela nella carità verso Dio e nell’imitazione di Gesù tramite l’obbedienza (“poi vieni e seguimi”): e questo è il vertice della vita cristiana.
Il consiglio della povertà indica in un certo senso la misura massimale del comandamento “Non rubare”; infatti, Paolo dice: “Chi era avvezzo a rubare non rubi più, ma si guadagni da vivere lavorando onestamente, per farne parte a chi non ne ha” [Ef 4,28]. Il consiglio della castità (distinta dal celibato) indica la misura massimale del comandamento “Non commettere adulterio”, spingendo a vivere in tutto e per tutto la dimensione sponsale dell’alleanza con Dio. Il consiglio dell’obbedienza indica la misura massimale del comandamento “Onora tuo padre e tua madre”, applicato al padre o alla madre spirituale (interpretazione classica nei Padri del deserto), secondo il versetto del Deuteronomio [32,7]: “Interroga tuo padre e te lo farà sapere; gli anziani, e te lo diranno”. Del resto Gesù stesso [in Mt 5] aveva già inteso i comandamenti in senso massimale (“avete inteso che fu detto, ma io vi dico…”). Resterebbe da considerare se i consigli a questo punto siano da intendere solo come consigli opzionali. L’amore tende infatti a massimizzarsi, e ad ogni cristiano, e soprattutto ai consacrati (in senso lato), Gesù come a Pietro chiede: “Mi ami tu più di costoro?”; e comanda: “Seguimi!”, in modo da dover “tendere le mani” e “farsi portare da altri” [Gv 21,15.18-19]. Il “di più” va inteso non ad esclusione degli altri (a tutti viene chiesto di amare “di più”), ma come impegno personale.
Al giovane ricco Gesù non fa però menzione del celibato. Altrove [cf Mt 19,11; Lc 20,35] il Vangelo aveva valorizzato il celibato (così la tradizione intende l’eunuchia per il Regno di cui parlava Gesù), come una condizione che anticipa il tempo “in cui non si prende moglie né marito”, ma aggiunge anche che non si tratta di un consiglio dato a tutti in ordine alla sequela, ma di una parola che “non a tutti è dato di intendere, ma solo a coloro a cui è stato concesso” per speciale vocazione di Dio [7].
C’è da aggiungere che la tradizione ascetica soprattutto recente ha preferito fondare i consigli evangelici non tanto (o non soltanto) su questi consigli di Gesù o Paolo, ma sulle stesse beatitudini [secondo l’elenco di Mt 5], che ne sono il sistema di valori sottostante: ossia, la povertà in spirito, la purezza di cuore, la fame e sete di giustizia (ovvero il desiderio di obbedire alla volontà di Dio), la mitezza (o umiltà) e la pace. Dire infatti “Beati i poveri in spirito” significa non solo congratularsi con tutti coloro che sono di fatto poveri perché è giunta la loro redenzione nel Regno (non solo futuro ma già presente), ma anche consigliare, col procedimento del macarismo, la scelta volontaria della povertà (anche questo potrebbe essere il senso dell’aggiunta matteana “in spirito”) [8].
A differenza dei padri e degli scolastici (che le intendevano perlopiù in senso mistico), le beatitudini sono così intese come espressioni delle virtù evangeliche, che sono al massimo grado, in quanto hanno già in se stesse il premio della gloria (“beati i poveri di spirito, perché di essi è il Regno dei cieli”). Ma anche fra le beatitudini non si fa menzione del celibato.
Per la reinterpretazione delle beatitudini in chiave ascetica, alla castità si può far corrispondere in primo luogo la “purezza di cuore” (intesa non solo, come in origine, quale atteggiamento di purezza morale contrapposta ad una purezza solo rituale, formalistica e ipocrita, ma quale virtù di far trasparire l’amore di Dio nell’amore umano); e in secondo luogo anche l’“afflizione” (da intendere come il lutto spirituale di Gerusalemme, vedova e derelitta, che viene consolata, redenta e sposata dal suo creatore [cf Is 60,15-16.20; 61,2-3; 62,4-5]). Insomma, la castità in questa luce consiste nella consapevolezza del proprio rapporto sponsale con Dio (nell’Alleanza, di cui la consacrazione non è che un segno ulteriore), da cui scaturisce la trasparenza interiore ed affettiva dell’amore, di cui la castità del corpo non è che un segno o sigillo (secondo la metafora del Cantico ripresa dai Padri del deserto).
A margine di queste considerazioni bisogna aggiungere che in passato la teologia ha commesso sovente l’errore di considerare i consigli evangelici puramente opzionali e riservati a una ristretta cerchia di persone.
Ambrogio nel trattato sui doveri (De officiis) ha tematizzato in senso cristiano (trasformando categorie già stoiche) la distinzione tra doveri medi (ossia i precetti validi per tutti) e doveri perfetti (ossia i consigli di perfezione). Ma la tradizione ascetica (ad esempio con Caterina da Siena, Francesco di Sales, Alfonso de’ Liguori, Antonio Rosmini) [9] e il magistero stesso (al quinto capitolo della Lumen Gentium del Concilio Vaticano II) hanno ribadito per tutti i cristiani il dovere (nel senso di chiamata) di tendere alla santità nella perfezione (nel senso di compimento) della carità, ciascuno secondo i doni e la misura di fede ricevuti. Certamente, da un punto di vista ascetico è molto educativo lasciare alla libera iniziativa e generosità della persona, come singola o anche inserita in una specifica comunità, una parte del lavoro di santificazione. Anche le regole più rigorose prevedono e incoraggiano la libera e generosa pratica personale di opere “supererogatorie”, in aggiunta a quelle prescritte per tutti [10].
In realtà, separare e addirittura opporre consigli e precetti è erroneo, giacché l’etica evangelica è contemporaneamente imperativa e ottativa [11]: al giovane ricco Gesù ha esposto i comandamenti in forma imperativa, ma solo dopo avergli premesso, a mo’ di consiglio: “Se vuoi entrare nella vita”. Viceversa, dopo che il giovane se n’è andato via triste, rifiutando i consigli per la perfezione, Gesù commenta: “Quanto è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli!”. In altre parole col suo rifiuto il giovane non solo rinuncia a un “di più” opzionale, ma rischia di compromettere la sua stessa fedeltà minimale ai precetti, condizione per entrare nella vita eterna. Nessun consiglio che dà Gesù è puramente opzionale, perché Gesù comanda di essere perfetti “com’è perfetto il Padre nei cieli”, e perché “l’amore perfetto scaccia il timore” servile e compie tutto ciò che piace all’Amato senza bisogno che questi lo comandi per precetto; peraltro la distinzione (non separazione) fra precetti e consigli va mantenuta, per evitare da una parte scrupoli e apprensioni, e dall’altra l’appiattimento e l’annacquamento delle virtù evangeliche in un generico comportamento da brave persone.
Dobbiamo dedurne che i consigli evangelici (e in generale la sequela del discepolato) nell’intenzione di Gesù sono dati a tutti (in diverso modo, a seconda dei talenti ricevuti, ma senza discriminazione di condizioni di vita), pur sapendo che non da tutti saranno accolti: “A tutti egli diceva: Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso” [Lc 9,23]. Il vangelo non ha preclusioni verso gli sposi, tanto è vero che Maria e Giuseppe erano davvero sposati, anche se in maniera del tutto straordinaria.
Corollario: l’imitazione di Cristo e di Dio essenziale alla consacrazione non comporta necessariamente il celibato.
La consacrazione, come dicevamo all’inizio, comporta una imitazione del Dio tre volte santo, tale da far passare l’uomo dalla semplice immagine naturale del Dio Trino, alla somiglianza sovrannaturale con lui mediante le virtù.
Nei consigli evangelici abbracciati con la consacrazione c’è di conseguenza una profonda imitazione di Cristo “mite ed umile di cuore”; così povero da “non aver dove posare il capo” [Mt 11,29 e 8,20]; così puro da essere “nel seno del Padre” e poter dire “Chi vede me vede il Padre” [Gv 1,18 e 14,9]; così obbediente al Padre da dire “Non la mia, ma la tua volontà sia fatta”, e di riflesso così obbediente ai suoi, da stare “loro sottomesso” [Lc 22,42 e 2,51].
I cristiani si fanno imitatori dei santi “così come lo sono di Cristo” [1Cor 11,1]; cercano di avere in sé “gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale […] spogliò se stesso” e “da ricco che era si fece povero per arricchire noi tutti”, e “si fece obbediente fino […] alla morte di croce” [Fil 2,5-8; 2Cor 8.9], per essere infine presentati “quale vergine casta a Cristo” [2Cor 11,2] [12].
Ebbene, colpisce il fatto che nel Nuovo Testamento il celibato non è presentato come imitazione di Cristo, il quale pure era celibe; segno che non si tratta di un elemento discriminante per la sequela ravvicinata del Maestro. Paolo stesso, nel consigliare il celibato, non dice: “Vorrei che tutti fossero come Cristo, ma purtroppo non tutti accettano o ci riescono”; ma dice: “Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno ha il suo carisma da Dio” [1Cor 7,7] (parlando come chi, entusiasta della propria vocazione, la vorrebbe condividere con tutti).
Certamente, che Cristo sia stato celibe facilita i celibi nell’imitazione di Cristo. E tuttavia, Cristo è contemporaneamente l’Agnello Vergine (di cui parla l’Apocalisse) e lo Sposo della Chiesa; per questo egli può essere lo Sposo dei celibi come degli sposi: entrambi, poi, con doni diversi imitano l’inimitabile.
[1] Cf Bernardo, De diligendo Deo; Kant, Fondazione della metafisica dei costumi (nella seconda parte della quale stabilisce che l’amore che si può comandare “è amore pratico, e non patologico”, ossia è amore deliberato, e non quello emotivo); Kierkegaard, Atti dell’amore (in 1.2A c’è una delle più belle analisi in proposito; cf anche Carlo Maria Martini, lettera pastorale Farsi prossimo; Jean‑Luc Marion, Étant donné (nella fenomenologia del dono).
[2] Agostino, Lettera 109.2 [in realtà pseudoepigrafica]; Confessioni, 10.29.
[3] Albani – Astrua, La dottrina spirituale di S. Giovanni della Croce, MIMEP, Pessano 1991, p. 25-26.
[4] Cf Stefano De Fiores, “Consigli evangelici”, in Stefano De Fiores – Tullo Goffi, Nuovo dizionario di spiritualità, Paoline, Roma 1979, p. 242-262 (in particolare il quarto punto, sul consiglio del celibato per il Regno [p. 246-249]). L’autore rileva come, nella esegesi e nella riflessione spirituale degli ultimi tempi si tenda a distinguere il celibato dagli altri consigli evangelici e a ridimensionare la lettura tradizionale in chiave celibataria di alcuni testi evangelici (come quello della eunuchia per il Regno o quello della vita come angeli del cielo).
[5] L’affermazione paolina non comporta che possano dedicarsi alla preghiera solo quanti si astengono dai rapporti (come intesero spesso gli Scolastici che, aristotelicamente, ritenevano incompatibile il piacere sessuale con la contemplazione [cf Tommaso, Summa, II‑II 186.4]), ma che l’astinenza è a sorgente e difesa di vita interiore. Quanto alla “breve durata” di tale astinenza, essa è suggerita non solo dal pericolo che uno dei due coniugi cada in tentazione, ma soprattutto dal carattere di reciprocità che l’atto coniugale ha [cf 1Cor 7,3-6].
[6] Alla luce di Tb 6,16-22 nel testo, modificato, della Vulgata (in cui l’angelo suggerisce a Tobia di passare dopo le nozze “tre giorni nella continenza”).
[7] Come si diceva, l’esegesi recente ha proposto anche altre interpretazioni dei due passi evangelici. Comunque, dato il contesto in cui ci muoviamo, ci soffermiamo sull’interpretazione tradizionale, in quanto ha ispirato autorevolmente la vita ecclesiale.
[8] Per quanto riguarda l’interpretazione esegetica delle beatitudini si veda il classico e monumentale studio di Jacques Dupont [Les Béatitudes, IIe éd., Nauwelaerts, Louvain 1958-1973, 3 vol.; trad. it., Le Beatitudini, Paoline, Roma 1973-1977, 2 vol.]. Si ipotizza una originaria distinzione tra i macarismi delle folle di poveri e affamati (in quanto destinati ad essere saziati materialmente dalla condivisione e spiritualmente dall’annuncio evangelico) e i macarismi dei discepoli perseguitati: i discepoli possono far propri i macarismi delle folle di poveri assumendo loro stessi volontariamente (“in spirito”) la povertà. Inoltre, dal punto di vista teologico, ci si è chiesti se la morale predicata nel discorso sulla montagna (quanto non solo alle beatitudini, ma anche al rifiuto del divorzio e addirittura alla rinuncia alla difesa violenta) sia vincolante per tutti gli uomini, oppure per tutti e soli i discepoli di Cristo, oppure per una loro parte soltanto, oppure sia addirittura un ideale impossibile da realizzare, proposto solo per far aprire meglio i credenti alla grazia. Cf Gerhardt Lohfink, Wem gilt die Bergpredigkt? Beiträge zu einer christlichen Ethik, Herder, Freiburg 1988; trad. it.: Per chi vale il discorso sulla montagna? Contributi per un’etica cristiana, Queriniana, Brescia 1990.
[9] Nel Dialogo della divina provvidenza di Caterina da Siena si spiega che non si possono osservare i precetti senza i consigli; nel Teotimo, Francesco di Sales considera i consigli come espressione della “volontà generale” di Dio (dunque il discernimento sarà sul come attuarli singolarmente); nella Pratica di amar Gesù Cristo di Alfonso de’ Liguori e nelle Massime di perfezione cristiana di Antonio Rosmini si propone a tutti i cristiani l’ideale della perfezione della carità.
[10] Per una ricostruzione della questione dell’etica supererogatoria (almeno con riferimento alla tradizione cattolica che si è rifatta a Tommaso, a confronto con quella luterana, cf Michael Konrad, Precetti o consigli. Studi sull’etica di San Tommaso d’Aquino a confronto con Lutero e Kant, Lateran University Press, Roma.
[11] Convenzionalmente si va affermando in filosofia la distinzione tra etica (ottativa, di ispirazione perlopiù aristotelica) e morale (imperativa, di ispirazione perlopiù kantiana). Per la loro distinzione e inseparabile connessione cf Paul Ricoeur, Éthique et morale (1990), pubblicato in trad. it. come Etica e Morale [in Carmelo Vigna (Ed.), L’etica e il suo altro, Angeli, Milano 1994, p. 217-227], ora ripubblicato in Etica e morale, Antologia a cura di Domenico Jervolino, Morcelliana, Brescia 2007, p. 33-52.
[12] Ma si tratta di una verginità spirituale, a cui tutti i cristiani sono chiamati, contro quella “fornicazione” spirituale che è costituita dall’idolatria e dalla infedeltà. Cf Ap 7,1-17 e 14,15: in questo testo i vergini sono quelli che portano il sigillo della consacrazione divina; anche se il testo è stato spesso letto dalla tradizione in relazione alla verginità come scelta di vita, questa interpretazione non è affatto esclusiva.